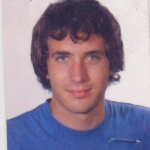L'Eritrea, situata nel Corno d'Africa lungo la costa del Mar Rosso, è stata la cosiddetta "colonia primogenita" italiana. Dal 1869, gli interessi italiani furono attratti dalla possibilità di avere una base navale e commerciale ad Assab. Tuttavia, il regno d'Italia non costituì ufficialmente la "colonia d'Eritrea" fino al 1890.
L'interesse italiano per l'Eritrea fu rilanciato da Benito Mussolini (1883-1945), che era determinato a elevare l'Italia fascista al rango delle altre grandi potenze. La colonia fu usata dunque come trampolino per l'invasione dell'Etiopia nel 1935-36 e divenne parte dell'Africa Orientale Italiana. Fu la colonia italiana più duratura fino a quando non fu occupata dai britannici nel 1941 e successivamente assorbita dall'Etiopia, dalla quale ottenne l'indipendenza nel 1991.

Perché l'Italia scelse l'Eritrea?
Durante l'età dell'imperialismo, tradizionalmente collocata tra il 1870 e il 1914, molte potenze europee estesero il loro controllo politico, militare ed economico su gran parte del globo. In questo contesto, l'Italia era l'ultima arrivata: mentre altri paesi cercavano di valorizzare i loro possedimenti, l'Italia si lanciava verso nuove conquiste. La prima colonia italiana fu l'Eritrea, che venne costituita ufficialmente solo nel 1890 con una dichiarazione formale dopo 21 anni di presenza italiana nell'area.
L'apertura del canale di Suez nel 1869 ebbe un impatto importante sulla traiettoria del colonialismo italiano. Il canale mise in collegamento il Mediterraneo all'oceano Indiano attraverso il Mar Rosso, ridisegnando il commercio marittimo globale e facilitando i collegamenti tra gli imperi europei e le loro colonie. Per queste ragioni, molti paesi iniziarono a fondare e rinforzare le loro basi lungo le coste del Mar Rosso e del golfo di Aden. La Gran Bretagna aveva già occupato Aden nel 1839 e l'isola di Perim nel 1857, che più tardi entrò a far parte del protettorato di Aden (1839-1857); la Francia si era già stabilita in quella che sarebbe diventata la Somalia francese (1872-1963); l'Egitto controllava il Sudan fin dal 1820 e nel 1865 ottenne il porto di Massaua dall'Impero ottomano, di cui gli egiziani facevano formalmente parte. [fuzzy]Il Mar Rosso divenne una delle aree geopolitiche più aspramente contestate.
Quella che oggi è conosciuta come Eritrea era allora un territorio contestato da varie potenze per la sua posizione strategica. L'area era stata formalmente sotto il controllo dell'Impero etiope come regno subordinato (chiamato Medri Bahri) che poi entrò a far parte dell'Impero ottomano. Il controllo ottomano era solo nominale e diverse parti della regione erano ancora governate da entità locali, come il sultanato di Aussa.

Le nuove opportunità offerte dal canale solleticarono le ambizioni di Giuseppe Sapeto (1811-1895), un ex-sacerdote che aveva fatto il missionario nel Corno d'Africa nella prima metà del XIX secolo. Sapeto elaborò il progetto per un porto marittimo sul Mar Rosso che avrebbe garantito i commerci italiani. Il governo italiano, guidato da Luigi Menabrea (1809-1896), venne a conoscenza di questa idea. La visione di Sapeto fu accolta con favore sia dalla monarchia italiana che da un gruppo di mercanti e armatori dell'Italia settentrionale. Questo sostegno portò il governo ad affidare a Sapeto la missione di esplorare le coste del Mar Rosso per acquistare una base navale adatta all’Italia. Dopo aver scartato le località di Khur Amera e Sheikh Said lungo la costa araba, che erano già state occupate, la missione si rivolse alla costa africana. La scelta finale cadde su Assab, un piccolo villaggio di pescatori. Il 15 novembre 1869, Sapeto firmò un accordo con l'impegno di comprare la baia di Assab con i due autoproclamatisi sultani di Raheita, i fratelli Ibrahim e Hassan ben Ahmad.
Il coinvolgimento del governo italiano e il sostegno britannico
Il governo italiano non voleva essere coinvolto direttamente in questa avventura coloniale. Sia il primo ministro Menabrea che il suo successore Giovanni Lanza (1810-82) temevano di provocare una reazione delle altre potenze. Il governo chiese all'armatore Raffaele Rubattino (1810-1881) di acquistare la baia a suo nome, con il pretesto di creare una base commerciale privata. L'11 marzo 1870 Rubattino concluse l'accordo dando così inizio al colonialismo italiano in Africa. Come poi si è scoperto, per otto anni Assab rimase in stato di abbandono: Rubattino non aveva interesse nel mantenere la base e i vari governi succedutisi negli anni Settanta dell'Ottocento non trovarono un uso specifico per questa micro-colonia. Allo stesso tempo, l'Egitto reagì a questa intrusione italiana nel Corno d'Africa. Solo pochi giorni dopo la partenza di Sapeto, delle truppe egiziane entrarono nella baia in segno di protesta per l'occupazione. Tuttavia, Rubattino tornò nuovamente a occuparsi di Assab: dopo che la Camera dei deputati rifiutò di finanziare il suo progetto per il prolungamento di una rotta marittima commerciale, egli tentò di convincere il governo a trasformare Assab in un grande porto che poteva essere utile come punto su cui far convergere il commercio etiope. Il nuovo governo, guidato da Benedetto Cairoli (1825-1889), incoraggiò una spedizione per rioccupare Assab. Cairoli non informò il parlamento, bensì tentò di ottenere l'approvazione della Gran Bretagna. Rubattino, scortato da una cannoniera britannica, arrivò ad Assab il 15 marzo 1880 e firmò un nuovo accordo - ancora a nome suo - con il sultano locale.
È interessante analizzare le ragioni dell'intervento britannico. Dopo il congresso di Berlino del 1878, che aveva compromesso l'integrità dell'Impero ottomano, portato la Francia a compiere nuovi sforzi nel Mediterraneo e dato inizio alle nuove ambizioni coloniali della Germania, per il colonialismo italiano iniziò una nuova fase. Durante gli anni Ottanta dell'Ottocento, Londra era sovraccaricata dai suoi impegni di potenza globale, e così decise di fare affidamento su un socio minoritario nel Corno d'Africa che evitasse intrusioni tedesche o francesi. Di fatto, fu grazie alla "benevolenza" britannica se il 10 marzo 1882 il governo italiano prese il controllo di Assab, che divenne ufficialmente un possedimento italiano e non più una proprietà privata. Il coinvolgimento ufficiale dell'Italia segnò l'inizio di una politica coloniale molto più audace. Ancora una volta, questo avvenimento fu la conseguenza della situazione internazionale dell'epoca. Nel 1881 la Francia impose un protettorato sulla Tunisia, un'area che era sempre stata un obiettivo delle aspirazioni coloniali italiane. La frustrazione per il cosiddetto "schiaffo di Tunisi", insieme alla nuova ondata di colonialismo europeo scaturita dalla conferenza di Berlino del 1884-1885, che aveva formalizzato e regolamentato la "corsa per l'Africa", incoraggiò l'espansione italiana. Inoltre, l'Egitto fu obbligato ad allentare la presa sul Corno d'Africa a causa del suo coinvolgimento nella guerra mahdista, una rivoluzione guidata da un movimento islamico che cercò di rovesciare il controllo egiziano del Sudan per poi iniziare una guerra che coinvolse il Corno d'Africa (1881-99).

Il primo scontro con l'Etiopia
Nel 1885, approfittando ancora della benevolenza britannica, il primo ministro Pasquale Stanislao Mancini (1817-88) ordinò l'occupazione della città portuale di Massaua sul Mar Rosso. In realtà, il progetto di Mancini era molto più ambizioso. Egli era convinto che il coinvolgimento italiano nel Mar Rosso poteva rappresentare la "chiave per il Mediterraneo" (Mancini, 1885): il sogno di una cooperazione anglo-italiana in Sudan era il primo passo del piano di Mancini per estendere il codominio italo-britannico nel Mediterraneo. Gli scarsi risultati dell'operazione militare causarono la caduta del governo Mancini, che era stato fortemente criticato dal parlamento per l'inutilità dell’operazione. Ciononostante, le truppe italiane in Africa mantennero un atteggiamento ostile occupando alcuni villaggi con un'azione che venne considerata una minaccia dal vicino Impero etiope.
L'Abissinia, nome con cui l'Impero etiope era frequentemente designato, era sempre stata sottovalutata dall'Italia. A quel tempo era guidata dal negus, titolo di cui si fregiava l'imperatore Yohannes IV (1837-89), che stava fronteggiando contemporaneamente la guerra mahdista alla frontiera con il Sudan e delle turbolenze interne. Uno dei più importanti vassalli dell'Etiopia, il re dello Scioà Menelik (1844-1913), era considerato dagli italiani uno dei loro alleati nella regione, in grado di minare l'autorità del negus e la coesione interna dell'impero.
Ciononostante, Alula Engida (1847-1897), uno dei più potenti capi militari etiopi e governatore della provincia in cui le truppe italiane avevano iniziato l'offensiva, il 27 gennaio 1887 attaccò e annichilì un battaglione di 500 soldati italiani presso Dogali. Sebbene l'operazione fu un'iniziativa interamente personale del ras Alula Engida, l'Italia decise di rispondere con una spedizione militare contro l'Etiopia. Nel 1887, al comando di Alessandro di San Marzano (1830-1906), vennero dispiegati 20.000 uomini. Nel frattempo, il diplomatico Pietro Antonelli (1853-1901) firmò un trattato segreto di neutralità con Menelik, sperando di indebolire gli etiopi. Nonostante la mobilitazione, la guerra prese una piega inaspettata perché Yohannes decise di ritirare il suo esercito (anche se era più grande di quello italiano) per poter fronteggiare i mahdisti. Questa mossa gli costò la vita: l'imperatore morì nella battaglia di Gallabat nel 1889.

La morte di Yohannes IV aprì la lotta per la successione al trono, che era reclamato da due pretendenti. L'imperatore, in punto di morte, aveva nominato Mangesha Yohannes come suo erede, che era supportato dal ras Alula Engida. Il rivale era Menelik, che era appoggiato dagli italiani e che aveva la fedeltà di gran parte dei dignitari etiopi. Menelik vinse la disputa e fu incoronato nel 1889. Nel 1889, venne siglato con il nuovo imperatore il trattato di Uccialli con lo scopo di promuovere buone relazioni diplomatiche e commerciali tra Italia ed Etiopia. Tuttavia, il trattato rappresentò la causa di uno dei più importanti scontri tra i due paesi poiché l'Italia affermava che tale documento stabiliva un protettorato sull'Etiopia. L'incomprensione, che fosse internazionale o no, deriva da una differenza di interpretazione tra amarico e italiano sulla traduzione dell'articolo 17 del testo, che permetteva all'Etiopia di servirsi dell'Italia nel campo della politica estera.
La nascita della colonia e la battaglia di Adua
Nello stesso momento, il primo ministro italiano Francesco Crispi (1818-1901) spinse fortemente per elevare il rango dell'Italia tra le grandi potenze. La sua politica estera senza scrupoli combinò un crescente militarismo con l'impegno coloniale. In tal senso, Crispi fu il primo a fornire una giustificazione per l'espansionismo italiano, postulando la necessità di combinare la politica coloniale con l'emigrazione. Quegli anni erano caratterizzati da un'emigrazione di massa sia dal Nord che dal Sud Italia, e l'Africa poteva fornire una risorsa alternativa di terra per i contadini poveri. Il collegamento tra colonialismo ed emigrazione sarebbe stato rievocato successivamente dal fascismo e da Benito Mussolini, che enfatizzò la ricerca di "un posto al sole" per l'Italia. Ritornando a Crispi, nel 1890 egli istituì ufficialmente la colonia eritrea, stabilendo la capitale a Massaua. Il nome Eritrea fu ispirato dall'antico nome greco del Mar Rosso, Erythra.
Nel corso di questi eventi, Menelik fu in grado di evitare ogni interferenza da parte italiana e nel 1893 denunciò la pretesa di un protettorato sul suo impero. Il controllo italiano si era allargato alle città di Asmara e Cheren, e la sua influenza era proiettata nella regione del Tigrai, all'interno dell'Etiopia. Il nuovo governatore dell'Eritrea, il generale Baldassarre Orero (1841-1914), era così sicuro della debolezza del nemico che decise di marciare verso la città di Adua, che aveva un'importanza religiosa particolare per la Chiesa ortodossa etiope, che era la più diffusa nell'impero. Per questa sua iniziativa non autorizzata, Orero fu destituito e rimpiazzato dal generale Antonio Gandolfi (1835-1902), a cui seguì un amico intimo di Crispi, Oreste Baratieri (1841-1901), le cui ambizioni però erano più grandi di quanto gli permettessero le truppe a sua disposizione. Egli provocò il potente vicino con diverse spedizioni militari oltre confine. Baratieri credeva che con una veloce occupazione del Tigrai avrebbe potuto minacciare la stabilità dell'Impero etiope e nel 1895 iniziò l'invasione. La situazione gli sfuggì rapidamente di mano: i capi etiopi alleati dell'Italia si ritirarono, la confusione regnava sovrana tra i comandi militari e le truppe italiane iniziarono a subire perdite significative.

Il 1° marzo 1896 accadde l'impensabile: presso il campo di battaglia di Adua, gli italiani subirono una cocente sconfitta, perdendo circa 6.000 uomini e 3.000 prigionieri. Fu la peggiore sconfitta di un esercito europeo nella storia del colonialismo. Questi fatti causarono un terremoto politico: il governo Crispi cadde e l'Etiopia si assicurò decenni di sovranità dopo una battaglia che divenne un simbolo per gli africani e le popolazioni di colore in generale. La sconfitta fu un trauma collettivo per l'Italia, che aprì la strada a sentimenti revanscisti che culminarono con l'invasione fascista dell'Etiopia nel 1935.
La gestione della colonia
L'Eritrea fu un possedimento isolato. La colonia fu affidata a Ferdinando Martini (1841-1928), il primo governatore civile, che ebbe il preciso compito di far dimenticare l'Eritrea agli italiani. Nonostante la perdita d'importanza, Martini iniziò a riorganizzare la colonia a partire dal 1898 scrivendo il primo Ordinamento, un insieme di leggi per l'Eritrea con il quale subordinava il potere militare all' autorità civile, elaborava un bilancio annuale e cercò, senza grande successo, di attrarre degli investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture. All'ombra del disinteresse generale per l'Eritrea, iniziarono a emergere le personalità dei singoli governatori. Il governo paternalistico di Martini, che identificava sé stesso con la colonia al punto di scrivere "la colonia sono io" (Martini, 328), non cambiò la relazione con i sudditi coloniali, verso i quali continuò a usare il pugno di ferro se non seguivano le sue disposizioni. Le relazioni con l'Etiopia migliorarono: Martini, dopo aver ampliato le sue relazioni internazionali e centralizzato il potere, instaurò buone relazioni con Martini, il quale preferì seguire una politica di buon vicinato con l'Etiopia invece di cercare vendetta. Tuttavia, la salute di Menelik peggiorava e molti paesi temevano una dura transizione dopo la sua morte. Nel 1906 Gran Bretagna, Italia e Francia siglarono un accordo tripartito con il quale stabilirono le loro rispettive sfere d'influenza all'interno dell'Etiopia.
Gli anni seguenti videro pochi cambiamenti in Eritrea, nonostante una rinnovata fermezza nel dibattito pubblico italiano stimolato dai gruppi di pressione a favore del colonialismo, che intendevano preparare e mobilitare l'opinione pubblica. L'invasione italiana della Libia nel 1911 e la Prima guerra mondiale (1914-18) rallentarono ulteriormente l'evoluzione della colonia poiché le truppe migliori furono impiegate altrove e la mancanza di manodopera bloccò qualsiasi sviluppo delle infrastrutture. Il periodo successivo alla fine della Grande Guerra fu ricco di delusioni per l'Italia, che aveva sperato di ricevere delle compensazioni coloniali con il Trattato di Versailles del 1919. Mussolini portò un drammatico cambio di stile, assegnando una grande importanza alla politica coloniale. Il Duce intendeva presentare l'Italia come una grande potenza e voleva vendicare l'umiliazione di Versailles.

Questa nuova impostazione incoraggiò i funzionari coloniali come Jacopo Gasparini (1879-1941), che divenne governatore dell'Eritrea dal 1923, un anno dopo la presa del potere del fascismo. Gasparini intraprese uno sforzo diplomatico personale verso lo Yemen, guidato dal 1918 dall'imam Yahya (1869-1949), che era in aperta opposizione al protettorato britannico di Aden: il governatore ottenne le simpatie dell'imam e fu in grado di stipulare un trattato con lo Yemen nel 1926, che fece dell'Italia il suo più importante socio politico ed economico. I britannici temevano che l'Italia potesse creare il suo "Canale di Suez" personale tra le coste dell'Eritrea e dello Yemen, che stava conducendo delle guerre nella penisola arabica grazie alle armi acquistate dagli italiani. I piani per un'Eritrea più autonoma, che fosse il centro di irradiazione della politica italiana nel Mar Rosso e nel Corno d'Africa, vennero fermati sul nascere da Roma, che temeva di compromettere le relazioni, in quel momento buone, tra l'Italia fascista e la Gran Bretagna. Da questo punto in avanti, il ruolo dell'Eritrea fu riorientato esclusivamente come base per il lancio dell'attacco e della successiva occupazione dell'Etiopia nel 1936.
Il colonialismo italiano e l'identità dell'Eritrea
Un aspetto importante per descrivere il rapporto tra colonizzatore e colonizzato fu il ruolo delle truppe indigene. Gli ascari, le truppe eritree al servizio dell'Italia, diedero un supporto fondamentale nelle numerose campagne militari combattute in Libia, Somalia ed Etiopia. Ciononostante, era loro preclusa la scalata dei ranghi militari nell'esercito. Con l'occupazione dell'Etiopia nel 1936, l'Eritrea, insieme alla Somalia italiana, divenne parte dell’Africa Orientale Italiana (A.O.I.). Nei piani di Mussolini, l'Eritrea era destinata a diventare il cuore industriale dell’A.O.I. Tra gli anni Venti e Trenta avvenne una massiccia trasformazione della colonia grazie all'aumento dell'immigrazione di coloni italiani. Nel 1945, dopo la capitolazione delle colonie, quasi 40.000 italiani lasciarono l'Eritrea. La città di Asmara, attuale capitale dell'Eritrea, fu ridisegnata come una "piccola Roma" in seguito a un processo di urbanizzazione e modernizzazione caratterizzato da uno stile architettonico modernista e nel 2017 è stata dichiarata sito patrimonio mondiale del l'UNESCO.

La "colonia primogenita" però fu la prima a essere attaccata dai britannici durante la Seconda guerra mondiale (1939-45). Nel 1941, dopo la caduta di Cheren, l'Eritrea venne occupata rapidamente dalle truppe britanniche, che mantennero un'amministrazione militare fino al 1949 e un protettorato appoggiato dalle Nazioni Unite fino al 1952, quando l'Eritrea fu assegnata all'Etiopia. Decenni di colonizzazione italiana, con l'adozione di politiche razziali che divisero i vari gruppi presenti sul territorio e la creazione di un confine artificiale tra Etiopia ed Eritrea portarono a una difficile coabitazione. Il colonialismo italiano ebbe senza dubbio delle ripercussioni sulla formazione dell'identità eritrea. Dopo un fallito tentativo di federalizzazione, l'Eritrea fu trasformata in una provincia etiope e fin dagli anni Sessanta la regione fu caratterizzata da un continuo stato di guerra che culminò nel 1991 con l'indipendenza dell'Eritrea.