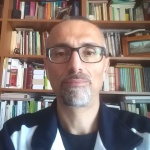Teodorico il Grande (c. 454-526 d.C.), noto anche come Flavio Teodorico, fu il Re degli Ostrogoti che, con l'impulso e la guida dell'Imperatore Zenone, invase l'Italia, depose il Re Odoacre e dal 493 al 526 d.C. regnò sui domini dei Romani e dei Goti. Alla nascita venne chiamato Dietrich (o Diederich), ragion per cui, egli nelle saghe germaniche è ricordato come Dietrich di Berna, l'eroe di tanti racconti della letteratura tedesca medievale, benché, tale identificazione, sia stata contestata da molti studiosi.
Era un cristiano di credo ariano, per quanto, nonostante le reali ostilità tra le due comunità religiose, la sua tolleranza verso il Cristianesimo niceno (trinitario) ed una rispettosa ed accorta politica nei confronti dei suoi sudditi, diedero stabilità e consenso al suo regno, fin alla sua tarda età. Tuttavia, a causa del crescente numero di nemici intorno a lui, finì per sentirsi minacciato in modo paranoico, ed iniziò a perseguitare i fedeli trinitari delle famiglie di alto rango appartenenti alla sua corte, tra i quali il filosofo Boezio ed il padre adottivo Simmaco. A Ravenna esiste ancora il suo mausoleo ed egli è ricordato come un governante giusto, comprensivo e saggio.
Infanzia, gioventù ed ascesa al potere
Teodorico, figlio del re degli Ostrogoti Teodemiro e di una delle sue concubine, nacque intorno al 454 d.C. Il nome datogli al battesimo era Dietrich ma, essendo stato inviato dal padre a Costantinopoli come ostaggio a garanzia del rispetto del trattato tra Bizantini e Goti, lo stesso venne romanizzato in Teodorico. Rimase dieci anni presso la corte bizantina, prima sotto la protezione dell'imperatore Leone I (r. 457-474 d.C.) e poi sotto quella di Zenone (r. 474-475 e 476-491 d.C.) e fu educato secondo i valori greco-romani. Non imparò mai né a leggere, né a scrivere, ma predilesse lo stile di vita ed il cerimoniale della corte di Costantinopoli, tanto da essere poi descritto dallo storico Sidonio Apollinare, come molto raffinato, sia nella vita privata che in quella pubblica.

Secondo quanto ne scrive Giordane (VI secolo d.C.) apparteneva alla famiglia degli Amali, che aveva regnato sui Goti sin da tempi remoti, ed era dunque di sangue reale (sebbene tale affermazione, come gran parte degli scritti di Giordane, sia stata contestata). Era appassionato di caccia e tirava in modo eccellente con l'arco. Inoltre sembra abbia mostrato una precoce predisposizione per il comando di uomini. Nel 483 d.C. venne nominato Magister Militum da Zenone e, l'anno seguente, fu eletto Consul, prendendo il nome di Flavio Teodorico.
La carica gli fu riconosciuta grazie al servizio reso all'impero nel saper contrastare ed arginare Teodorico Strabone (il guercio), un altro capo ostrogoto che era solito prendere di mira e depredare i territori imperiali, quando non era impegnato a combattere per la propria causa. Sia Teodorico degli Amali che Teodorico il guercio, erano considerati re dei rispettivi gruppi familiari di Goti e si contendevano la migliore considerazione dell'impero mentre, a turno, si dedicavano a fare scorrerie nei territori imperiali, qualora ritenessero di non essere stati trattati con sufficiente riguardo o non aver avuto assegnate quote sufficienti di uomini da occupare nei contingenti militari. Lo studioso Guy Halsall, a tal proposito scrive:
Tra il 474 ed il 478 un aggrovigliato carosello di alleanze, tradimenti, omicidi ed intrighi, minò costantemente la stabilità del sistema di potere romano. L'imperatore, infatti, in alcuni frangenti dovette affidarsi all'aiuto dei Goti per arginare altri avversari, ma, allo stesso tempo, non poteva permettere agli stessi Goti di acquisire più influenza. L'imperatore Zenone, appartenente agli Isaurici, ma osteggiato dalla sua stessa famiglia, i cui componenti erano desiderosi di monopolizzare la corte di Costantinopoli, s'impegnò in prima persona con qualche successo per mettere nuovamente l'un contro l'altro i due Teodorico, fino al 483-484 quando, a quanto pare, esagerò un po'. Il Guercio fu vittima di un incidente e finì per essere infilzato da una lancia, cadendo dal suo cavallo. Nelle vicende susseguenti Zenone spinse Teodorico degli Amali (Blandendolo con molte promesse, tra cui il Consolato) ad assassinare Recitach, il figlio del Guercio. Ma tale strategia, al posto di semplificare i giochi, eliminando una delle fazioni, condusse i Goti di Recitach ad unirsi all'Amale ed alla fine Zenone, invece di due gruppi, si trovò a fronteggiare una sola e potente forza militare. (286-287)
La Campagna d'Italia
Dopo la morte di Recitach e l'accorpamento dei reparti di Goti in precedenza sotto il suo comando, Teodorico fu inviato da Zenone contro un suo rivale, il generale Illus, messosi a capo di una rivolta contro gli Isaurici, in Asia Minore. Sconfitto che ebbe Illus, spegnendo così la sommossa, Teodorico ormai sulla via del ritorno, marciò con il suo esercito verso Costantinopoli. Avendo sconfitto entrambi i suoi rivali, i Goti e gli Isaurici, si trovò ad essere a quel punto, il più quotato tra i capi militari della regione, e decise quindi di prendersi quello che egli pensava di meritare, ma che nessuno gli aveva proposto: l'assegnazione di un territorio per la sua gente e la sua legittimazione come loro re. Iniziò così un'azione sistematica di contrasto a quell'impero e a quel medesimo imperatore che l'aveva portato al potere. Essendo cresciuto a corte, Teodorico conosceva bene quelle dinamiche grazie alle quali una carica militare poteva diventare una carica politica, e si rivolse allora contro quelle città alle quali, fino ad allora, aveva garantito la protezione. Halsall scrive:
I Goti devastarono i Balcani, arrivando a minacciare Costantinopoli, senza però riuscire a prenderne la Capitale, mentre Zenone, al sicuro dietro la tripla linea di mura della città, molto difficilmente avrebbe potuto portare altrimenti quest'ultimi fuori dai suoi domini. C'era la necessità di trovare una soluzione accettabile per tutti, rispetto alla situazione di stallo creatasi, e così fu: Teodorico sarebbe andato in Italia, a risolvere il problema del "tiranno" Odoacre. Nel 488 gli Ostrogoti si diressero verso l'Ovest.(287)
Pur essendoci dubbi su chi abbia proposto per primo, tra Zenone e Teodorico, l'invasione dell'Italia, è certo che ciò fosse, per Zenone, la soluzione di due problemi urgenti.
Odoacre (r. 476-493 d.C.) aveva regnato sull'Italia, con il benestare di Zenone, sin dal 476 d.C. ma portando all'imperatore una serie crescente di problematiche. Odoacre, dopo aver arginato la rivolta di Illus si era impunemente annesso la Dalmazia, comportandosi più come un monarca indipendente, che come il governatore di una provincia romana. Zenone doveva in qualche modo liberarsi sia di Odoacre, sia di Teodorico, e proprio per questo si ritiene che egli considerasse tale soluzione la migliore, dal momento che alla fine uno avrebbe ucciso l'altro, ed allora a lui sarebbe rimasto un solo problema da affrontare.
Teodorico, da parte sua, vide nella campagna l'opportunità di aggiungere nuova gloria alla sua carriera militare e, vincendo, di conquistare territori per il suo popolo, legittimando così il suo ruolo di loro sovrano. Invase, dunque, l'Italia, portandovi la distruzione, ed incontrò la prima resistenza dalla tribù dei Gepidi, presso il fiume Vuka, nel 488 d.C. Non è chiaro se i Gepidi agirono in qualità di alleati di Odoacre, o se, semplicemente, stessero cercando di proteggere le loro terre dall'invasione, ma ad ogni modo essi furono rapidamente battuti e decimati dalle truppe di Teodorico. Lo stesso continuò poi la sua marcia, fino a scontrarsi con l'esercito di Odoacre nella Battaglia del Ponte sull'Isonzo, il 28 agosto del 489 d.C., dove Odoacre fu sconfitto. Subito dopo quest'ultimo batté in ritirata verso Verona, inseguito da Teodorico. Gli eserciti arrivarono di nuovo allo scontro il 29 settembre seguente; Odoacre fu ancora una volta sconfitto. Poi fuggì verso Ravenna ad organizzare la difesa della città, mentre Teodorico continuò a conquistare territorio su territorio, in tutto il paese. Lo studioso Hewing Wolfram scrive a riguardo:
La marcia di Teodorico verso l'Italia sembrava destinata ad una veloce e risolutiva vittoria. A Milano, dove giunse dopo aver preso Verona, i dignitari laici ed ecclesiastici lo accolsero come il legittimo rappresentante dell'imperatore. Persino Tufa, il comandante in capo di Odoacre, insieme alla gran parte dell'esercito sconfitto, si unì alle schiere del vincitore.(281)
Assecondando l'atto di sottomissione ed alleanza di Tufa, Teodorico lo inviò, al comando delle sue truppe migliori, a Ravenna, per catturare Odoacre. Ma Tufa stava soltanto simulando la sua fedeltà al conquistatore, e finì per tradire le guarnigioni in favore dei soldati di Odoacre; le truppe d'élite vennero sterminate, e "Teodorico dovette subire la sua prima seria sconfitta sul suolo italiano" (Wolfram, 281). Odoacre ne approfittò per uscire da Ravenna ed ingaggiare combattimento col nemico, che lo respinse ripetutamente. Tufa si scontrò in battaglia con Federico dei Rugi nell'agosto del 491 d.C., ed entrambi trovarono la morte negli scontri.
Le ostilità proseguirono fino al 25 febbraio del 493 d.C., allorquando il vescovo di Ravenna, Giovanni, riuscì a negoziare un accordo secondo cui, Teodorico ed Odoacre avrebbero governato insieme. Teodorico si affrettò a sottoscrivere l'accordo, giungendo a Ravenna il 5 marzo del 493 d.C. ed il 15 dello stesso mese, nel corso di una cena tenutasi per suggellare il trattato, uccise Odoacre, pugnalando a morte. Le ultime parole di Odoacre furono: "Dov'è Dio?", alle quali Teodorico rispose: "Questo è quello che hai fatto alla mia gente", riferendosi alla sua presunta oppressione dei Goti in Italia, ed alla carneficina perpetrata a danno dei Rugi, alleati dei Goti medesimi. Il Wolfram così ci descrive le conseguenze della morte di Odoacre:
La natura volontaria e premeditata dell'azione compiuta da Teodorico è nettamente dimostrata dagli eventi successivi: non fu permessa una sepoltura cristiana delle spoglie umane di Odoacre e la moglie Sunigilda venne lasciata morire di fame. Invece, il fratello di Odoacre, Onulfo, si rifugiò in una chiesa, dove divenne mira degli arcieri goti...il giorno stesso dell'assassinio di Odoacre, i suoi seguaci e i suoi familiari furono sterminati. Ovunque i Goti riuscirono a mettere le mani su di loro, lì trovarono la morte. Nell'anno 493 Teodorico divenne l'incontrastato padrone dell'Italia. (284)
Odoacre aveva regnato con saggezza e quello ereditato da Teodorico era un regno che godeva di un sostanziale benessere. Tuttavia i territori erano sfiancati da anni di guerre, e così il più impellente problema ad impegnare Teodorico era una diffusa opera di ricostruzione.
I primi anni di regno di Teodorico e la sua legittimazione
Teodorico, portando avanti la ricostruzione del paese, che era stato devastato tra il 488 ed il 493 d.C., riuscì altresì a consolidare il suo potere. Molte delle foreste erano andate distrutte, o perché date alle fiamme durante le operazioni militari, o perché utilizzate come materia prima nei sistemi di difesa. L'impoverimento del patrimonio boschivo aveva ridotto la capacità di drenaggio dei terreni, con la conseguenza di regolari inondazioni di intere regioni, mentre altre erano ridotte all'aridità dall'ospitare di continuo scontri e battaglie. Teodorico si occupò allora di bonificare le paludi, di impiantare nuovi boschi, riuscendo a sfruttare, altresì, le conoscenze di esperti scavatori di pozzi, per creare nuove canalizzazioni e sistemi di irrigazione, che fossero utili a rendere nuovamente produttivi i terreni.

Egli governò su una popolazione in cui c'erano sia Goti che Romani, ed emise editti col fine di assicurare ad ognuna di queste componenti un'uguale tutela davanti alla legge. Inoltre gli si presentava un'ulteriore divisione all'interno del paese, quella religiosa tra i gli aderenti al credo niceno-trinitario, perlopiù Romani, ed i seguaci di quello ariano, prevalentemente Goti. Teodorico, pur appartenendo egli stesso al credo ariano, prescrisse la tolleranza delle differenti religioni, sperando di unire in tal modo tutti i territori italiani sotto il suo comando, senza differenza di nazionalità o religione. A tal fine, secondo il suo intendimento, aveva necessità di legittimare il suo passato, creando per sé e per la sua gente, un'ascendenza meritevole di un re, che potesse essere rispettata sia dai Goti che dai Romani.
La fonte principale della storia dei Goti è la "Getica" di Giordane, scritta nel VI secolo sulla base di un precedente lavoro di Cassiodoro (c. 485-c. 585 d.C.), capo dell'amministrazione teodoriciana e, quindi, sovrintendente di tutti gli scribi. Cassiodoro era romano e perciò la sua storia dei Goti è pervasa di ideali romani, ed allo stesso modo il racconto era destinato ad un pubblico di Romani (ugualmente farà Giordane in seguito). Lo studioso Roger Collins scrive:
L'attenzione nel documentare la continuità nella linea ereditaria di una casa regnante, era in modo prevalente più il prodotto di congetture circa le regole delle società germaniche, che qualcosa di realmente interessante per quelle stesse società. Nella prima metà del VI secolo, il regime Ostrogoto in Italia aveva bisogno di una storia e di un sistema istituzionale tale da potersi armonizzare con le richieste e le aspettative della classe dominante romana, dalla quale dipendevano largamente la collaborazione e l'efficienza. Classe dominante cui piaceva, senza dubbio, poter rivendicare la continuità delle grandi famiglie del tempo, con l'aristocrazia della Repubblica e dell'Impero. (104-105)
Si ritiene che nella sua storia (andata dispersa) dei Goti, Cassiodoro riportasse alcuni aspetti autentici, inserendoli in uno schema appartenente alla tradizione latina ed aggiungendovi quegli elementi che, secondo l'autore, erano adatti al precipuo fine di dare nobili ascendenti ai coevi governanti del paese. È stato altresì sottolineato come sia lo stesso Giordane a scrivere che egli "diede un'origine ai Goti nella storia di Roma" e, poiché seguiva la traccia di Cassiodoro, si ritiene che anche il precedente avesse fatto questo.
Non sappiamo quale riscontro possa aver avuto l'opera di Cassiodoro sulla popolazione nel suo insieme, tuttavia è certo che essa contribuì ad accreditare Teodorico presso l'élite romana e, che egli sia stato o meno un discendente della stirpe degli Amali (ed indipendentemente dal fatto che la stessa stirpe abbia realmente svolto il ruolo attribuitole da Cassiodoro), egli poteva a quel punto essere considerato il legittimo capo dei Romani, piuttosto che un re barbaro. Al tempo in cui Teodorico aveva ucciso Odoacre, Zenone era morto e gli era succeduto, come imperatore, Anastasio I, che nel 497 d.C. riconobbe Teodorico re dei Goti e dei Romani.
Politiche e Programmi
Sebbene avesse ricevuto la sua legittimazione sulla carta, e fosse ora anche ufficialmente nominato dall'Impero, Teodorico comprese di aver bisogno di ben ulteriori appoggi per consolidare il suo potere. Non a caso intorno al 494 d.C. diede in moglie al Re dei Visigoti Alarico II, Teodegota, una delle sue figlie e, nel 496 d.C. un'altra figlia, Ostrogota, andò in sposa a Sigismondo dei Burgundi. Egli stesso, dopo poco dalla vittoria del 493 d.C. su Odoacre, sposò Audefleda, sorella del Re dei Franchi Clodoveo I. Attraverso queste alleanze matrimoniali egli sperava di avere un regno nel quale tutte quelle genti che in precedenza erano conosciute dai Romani come "Tribù di Barbari", potessero vivere pacificamente insieme. L'Enciclopedia Cattolica commenta tali risvolti affermando:
Fiero delle sue origini gote, Teodorico credeva fosse possibile conciliare gli interessi romani e quelli germanici. Egli reputava la sua gente uguale ai Romani in merito alle antiche origini ed al prestigio militare, concludendo che il suo potere si basava esclusivamente sul valore dei Goti. In apparenza il suo regno era una continuazione dell'Impero Romano, ma in realtà le sue scelte politiche ebbero una naturale ed opposta contraddizione con gli ideali romani, secondo i quali tutte le differenti individuali nazionalità dovevano confluire e perdersi nell'unitarietà dello Stato. Tale strategia di potere, per cui le nazionalità andavano soppresse, venne contrastata da Teodorico; egli ebbe, infatti, un profondo rispetto dell'indipendenza nazionale ed a più riprese si schierò in armi, col fine di difenderle. (1)

La sua corte comprendeva uomini di ogni nazionalità e, così come aveva fatto Odoacre prima di lui, si impegnò a fondo nel mantenere la pace tra i suoi sottoposti, evitando di favorire gli appartenenti alla sua gente, rispetto agli altri. L'Editto di Teodorico del 512 riformò la sua prima legislazione, dichiarando in modo netto che ogni appartenente al regno poteva rivendicare gli stessi diritti riconosciuti dalla legge, che nello specifico erano le norme penali. Sebbene non sapesse né leggere, né scrivere egli fu un grande promotore dell'istruzione, amava le dispute filosofiche. Favorì l'alfabetizzazione del popolo e tenne con sé, presso la sua corte, il filosofo Boezio (480-524 d.C.). Consentì che ai suoi sudditi fossero offerti regolarmente spettacoli circensi, come in un revival dei tempi migliori dell'Impero, preoccupandosi di stabilire le modalità di distribuzione gratuita di cereali per i poveri.
Diede lavoro ad un largo strato della popolazione, varando un ampio programma di edilizia pubblica, e su ciò Collins nota:
Il programma di edilizia pubblica varato da Teodorico, che prevedeva opere nuove ed il restauro di altre già esistenti, era molto più ampio [di quanto non avesse fatto Odoacre] ed includeva la creazione e la riparazione di acquedotti, terme, mura di fortificazione urbane e palazzi - quest'ultimi sarebbero stati edifici dell'amministrazione pubblica, piuttosto che private abitazioni - in un gran numero di città, tra le quali Roma, Ravenna, Verona e Pavia. (108)
L'adozione di una politica di tolleranza religiosa favorì senz'altro la pace tra le varie fedi, consentendo di comprendere che ogni credo religioso aveva un'uguale dignità, mentre fu grazie alla sua abilità diplomatica che riuscì ad assicurarsi la pace con i regni confinanti.
Declino e morte di Teodorico
Nonostante tutti i risultati raggiunti, Teodorico incontrò di continuo sfide ed ostacoli. Nel 507 Clodoveo I, che sarebbe dovuto essere uno dei suoi alleati, sconfisse Alarico II, uccidendolo, dopodiché i Franchi si rifiutarono di intervenire quando i Burgundi, fino ad allora ritenuti una nazione amica, iniziarono ad intraprendere incursioni contro le coste italiane. Teodorico inviò allora le sue truppe a contrastare i Burgundi, riuscendo a difendere i confini del regno, ed addirittura ad ampliarli nel 513. Ad ogni modo dovette costantemente destreggiarsi tra i suoi alleati, nello sforzo di mantenere la pace, mentre era sempre necessario affermare il ruolo di Roma verso l'Oriente. Tra le altre sue preoccupazioni c'era altresì quella di non riuscire ad avere un erede maschio per la successione al trono, che lui sapeva essere un elemento necessario in vista di un riconoscimento della sua dinastia presso le istituzioni dei Romani.
Non essendo giunto il tanto atteso erede, nominò dunque il nipote Atalarico come suo successore. Atalarico era il figlio di Amalasunta, sorella di Teodorico, e del principe Visigoto Eutarico. Quest'ultimo era morto poco dopo il matrimonio ed Amalasunta era rimasta vedova, cosicché il giovane principe Atalarico era rimasto l'unica scelta possibile, ma ancor di più, designandolo come suo erede, Teodorico aveva portato il regno dei Visigoti sotto il suo controllo, dal momento che il legittimo successore di quel regno era ora associato al trono d'Italia.
Sentendosi così oltremodo rassicurato sul suo governo, Teodorico ebbe un notevole cambiamento nella vita pubblica, come anche in quella privata. Halsall scrive a riguardo: "Adottò gradualmente uno stile quasi imperiale. Teodorico, infatti, non aveva mai osato tanto nei primi anni di regno, ma col tempo ciò diventò sempre più evidente, fino alle ultime fasi, quando era palese un avvenuto cambio di mentalità"(290). In parte, tale nuovo atteggiamento, era dovuto ad una più convinta adesione al credo ariano, cui egli apparteneva, ed andava a scapito degli aderenti al credo trinitario.
L'imperatore Anastasio I era morto nel 518 e dopo di lui era salito al trono Giustino I (r. 518-527), mentre poi era stata la volta del giovane nipote Giustiniano I (r. 527-565). Sotto il comando di Giustino, Giustiniano aveva già giocato un ruolo determinante nel perseguire strategie politiche, e tra queste c'era la persecuzione dei Cristiani Ariani di Costantinopoli. Giustiniano era un trinitario e considerava l'Arianesimo un pericolo per la "Vera Chiesa". In risposta a ciò Teodorico, in Italia, diede inizio ad una propria persecuzione degli aderenti al credo niceno-trinitario, accrescendo così la tensione tra il suo regno e Costantinopoli.
Nel 523, Albino, console emerito, fu accusato di tradimento per via di una sospetta corrispondenza con l'Imperatore Giustino. Il Filosofo Boezio si erse a sua difesa, ma venne accusato egli stesso, ed in seguito messo a morte; il padre adottivo, Simmaco, lo seguì dopo poco. L'epurazione dei cattolici trinitari sarebbe senz'altro andata avanti in modo spedito, ma la salute di Teodorico iniziò a declinare e nel 526 d. C., dopo 30 anni da re, egli morì.

Anni seguenti ed eredità
Dopo la morte di Teodorico, gli successe il nipote Atalarico, ma dal momento che aveva soltanto dieci anni, non essendo in grado di esercitare il potere, la sorella di Teodorico, Amalasunta (v. 495. c.-535) salì al trono come reggente. Lei era una sostenitrice della cultura e dei gusti romani, tanto da affidare il figlio ad educatori romani, i quali sfruttarono il loro ruolo per iniziare il principe ai piaceri del vino, fino all'abuso, che si dice contribuì alla sua morte prematura nel 534; tra il 534 ed il 535, dunque, Amalasunta regnò come regina.
La stessa intavolò una trattativa con Costantinopoli e Giustiniano I, col fine di ottenere sostegno nel consolidare la sua posizione, ma da tale tentativo non scaturì nulla di concreto. Pertanto si rivolse ad un fidato cugino, Teodato, invitandolo ad assumere in coabitazione la carica di sovrano, ed egli rispose, accettando di buon grado. Di lì a poco Amatalsunta venne arrestata ed esiliata in una villa, sull'isola Martana (Lago di Bolsena - VT), là dove, sempre su ordine di Teodato, nel 535 finì strangolata dai suoi inservienti durante il bagno.
Dopo tali eventi, il cognato di Amalasunta, Witige (conosciuto anche come Vitige) si ribellò a Teodato, riuscendo a sopprimerlo e, nel 536 d.C., divenne egli stesso re. Regnò poi sull'Italia fino a quando, nel 540 fu sconfitto ed imprigionato da Belisario. A seguito della vittoria su Witige, i Goti avrebbero voluto affidare il regno a Belisario, ma egli, leale all'imperatore Giustiniano I, ingannò i cospiratori fingendo di accettare per poi farli arrestare. Cosicché Belisario, essendo riuscito ad azzerare l'intero gruppo dirigente dei Goti, rivendicò per Giustiniano I e per l'impero bizantino, tutto il territorio italiano.
Sebbene Teodorico non giunse a perseguire fino in fondo i propositi di tolleranza religiosa, così come accadde, nonostante la sua abilità diplomatica, nel dover confrontarsi con Costantinopoli, egli è tutt'ora ricordato come "il grande", grazie al suo sforzo di unificare le genti che abitavano il suo regno in un solo popolo ed inoltre, ancor di più, per aver ricostruito l'Italia sia piantando alberi e bonificando terreni, sia costruendo nuovi edifici o riuscendo ad arginare le forze ostili. Il suo ideale di un regno di nazionalità unite, benché indipendenti, che potessero convivere pacificamente sotto lo stesso governo, era prematuro per quei tempi.
Nemmeno Alessandro Magno, che prevalentemente aveva concesso agli appartenenti ai territori da lui conquistati di mantenere un certo grado di autonomia, in cambio del sostegno alla sua causa, non aveva favorito il medesimo tipo di orgoglio nazionale espresso dai popoli sottomessi da Teodorico. Lungo i trent'anni del suo regno, Teodorico unì sotto la sua egida i Goti e i Romani, mantenendo tra di essi la pace, e adoperandosi nel dare a tutti loro un maggiore benessere. Risollevò l'Italia dalle proprie rovine, restituendole stabilità e prosperità, ed in alcuni casi il prestigio perduto.
Fu sepolto con ogni onore nel mausoleo costruito per lui a Ravenna e, benché lo stesso venne profanato nel 540, successivamente alla vittoria di Belisario sui Goti, dopo essere stato restaurato, è tutt'ora visitabile. Teodorico è ricordato come "Il Grande" per aver revitalizzato l'Italia e, allo stesso tempo, per aver regnato su popolazioni differenti, senza costringerle ad assimilarsi in un'identica cultura.
Permane di lui dunque, fino ai nostri giorni, la memoria di un grande sovrano che regnò con grande saggezza, avendo l'ambizione di unire in uno stesso regno popolazioni distinte, ma con uguali diritti. La persecuzione dei Cristiani di credo trinitario, da lui voluta nella parabola discendente del suo regno, è considerata una risposta irrazionale alla politica anti ariana voluta da Giustiniano a Costantinopoli, piuttosto che una volontà consapevole e programmata di discriminare, e la sua memoria è ancora onorata grazie alla capacità avuta di essere fedele ad un ideale, con tutti gli sforzi fatti per realizzarlo.