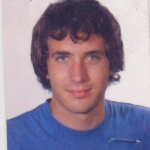Uno dei più ambìti progetti della politica coloniale italiana fu quello di assicurarsi una colonia africana nel Mediterraneo. Per questo motivo, l'Italia combatté e vinse la guerra italo-turca del 1911-1912 per il controllo della Tripolitania e della Cirenaica. Questi due possedimenti nel Nordafrica furono uniti successivamente nel 1934 per formare la colonia della Libia, che rimase sotto il controllo italiano fino al 1943.
In Tripolitania e Cirenaica ci furono scontri continui tra gli italiani e i movimenti di resistenza libici. Il conflitto durò fino al 1932, quando una campagna di 'pacificazione' condotta durante il governo fascista di Benito Mussolini (1883-1945) represse violentemente la ribellione.

I preparativi diplomatici per l'invasione
Uno degli obiettivi a lungo termine della politica coloniale italiana era quello di espandersi sull'altra sponda del Mediterraneo. Gli appetiti italiani si diressero inizialmente verso la Tunisia ma, nel 1881, la Francia impose un suo protettorato frustrando le ambizioni italiane. La mossa francese venne percepita come un'umiliazione, e da quel momento fu spesso definita come lo "schiaffo di Tunisi"; le possibilità di trovare una alternativa adatta per un avamposto italiano in Nordafrica diminuirono. Per questo motivo l'attenzione si spostò sulla Tripolitania, dato che era uno dei pochi posti liberi dal controllo delle altre potenze europee e poteva costituire un'utile base navale strategica nel Mediterraneo. La Tripolitania è la regione costiera settentrionale dell'attuale Libia, che all'epoca era un vilayet, cioè una provincia semi-autonoma dell'Impero ottomano (1299 circa-1922)
La sovranità ottomana era più nominale che effettiva: tra il 1711 e il 1835 la regione fu virtualmente indipendente sotto il dominio della dinastia locale dei Karamanli. Persino dopo che gli ottomani restaurarono il controllo sulla Tripolitania nel 1835, l'area rimase sotto l'influenza politica e religiosa dei Senussi. Questa confraternita era stata fondata nel 1837 da Muhammad ibn Ali al-Sanusi (1787-1859), un mistico algerino che voleva ripristinare le pratiche originarie dell'Islam. Grazie a una efficace integrazione all'interno del sistema tribale libico, i Senussi divennero presto un importante centro di potere che successivamente sarebbe stato in grado di coordinare la resistenza contro l'invasione italiana.
Ritornando all'Italia, la stampa nazionalista di metà del XIX secolo enfatizzava la possibilità di trasformare la Libia in una terra fiorente per gli emigranti italiani, facendola diventare il futuro centro dei commerci africani. Tuttavia, il governo italiano era ben consapevole che la Libia aveva poche risorse naturali - il petrolio sarebbe stato scoperto solo nel 1955 - e una colonizzazione demografica si sarebbe rivelata un progetto arduo. Inoltre, al momento dell'invasione, in Libia erano presenti meno di 1.000 italiani; pertanto, era impossibile giustificare una guerra per proteggere gli italiani all'estero. Così come per il colonialismo italiano in Eritrea, la giustificazione principale fu quella del prestigio di potersi sedere al tavolo delle grandi potenze. I primi piani per un intervento in Libia vennero ideati subito dopo lo "schiaffo di Tunisi" e, successivamente, l'Italia entrò in azione in seguito a una concatenazione di eventi.

Ciononostante, era fondamentale unire la preparazione militare agli sforzi diplomatici per giustificare un intervento in Libia. A quel tempo, l'Italia faceva parte della Triplice Alleanza insieme all'Impero austro-ungarico e al Reich tedesco, a loro volta alleati dal 1879. Questo nuovo patto militare fu un'altra conseguenza dello "schiaffo di Tunisi" e venne siglato nel 1882, segnando la fine di un lungo periodo di amicizia tra il regno d'Italia e la Francia. Anche se, nel 1891, gli italiani ricevettero rassicurazioni dai loro nuovi alleati per quanto riguarda il supporto alle loro pretese coloniali, era impossibile ottenere qualsiasi vantaggio nel Mediterraneo senza il consenso delle potenze che lo dominavano, vale a dire Francia e Gran Bretagna. In più, in quel momento, l'Italia doveva rivedere la sua politica coloniale dopo la sconfitta di Adua nel 1896 contro l'Impero etiope, che aveva bloccato l'espansionismo italiano nel Corno d'Africa. Pertanto, il Mediterraneo diventò ancora più importante per la marina italiana a causa dell'incerta situazione nel Mar Rosso. Francia e Gran Bretagna si erano già messe d'accordo sulle rispettive sfere d'influenza con la convenzione anglo-francese del 1890. L'Italia, dunque, si vide costretta a cercare un riavvicinamento con la Francia e, in seguito a una serie di contatti diplomatici, venne siglato l'accordo italo-francese del 1901, al quale seguì un simile patto anglo-italiano nel 1902. Questa triangolazione diede all'Italia il via libera in Tripolitania in cambio della promessa di non interferire con gli interessi britannici nel Mediterraneo e con le pretese francesi sul Marocco.
La preparazione internazionale fu accompagnata da una pervasiva politica domestica. Il tema della Libia venne spinto dai colonialisti e dalla stampa. Il Banco di Roma, uno dei principali istituti di credito italiani, iniziò a fare investimenti notevoli in Tripolitania. A questo vanno aggiunti i calcoli di politica interna del primo ministro Giovanni Giolitti (1842-1928), una delle figure politiche più importanti in Italia, che durante il suo mandato fu l'artefice di un'importante espansione economica e di progressive riforme sociali, come l'introduzione del suffragio universale maschile nel 1912. Inoltre, politicamente Giolitti non aveva scrupoli e va segnalata la sua arte del trasformismo, cioè la pratica politica di creare coalizioni di governo (fin troppo) flessibili. Fu anche spesso associato a episodi di corruzione. La guerra in Libia fu un modo per rafforzare il suo governo cercando l'appoggio di nazionalisti e conservatori liberali.
Un altro fattore importante era la condizione in cui versava l'Impero ottomano. Nel 1876, Abdul Hamid II (1842-1918) divenne il sultano, aprendo la strada a decenni di dominio assolutista. Era presente un ampio movimento di opposizione al sultano, i cosiddetti Giovani Turchi, che chiedevano una costituzione. Nel 1908 la loro rivoluzione contro il sultano portò a un periodo di restaurazione del sistema parlamentare, ma fu anche la causa di instabilità interna e debolezza internazionale. Nel 1908, la Bulgaria dichiarò la sua indipendenza dal dominio ottomano e l'Impero austro-ungarico annesse la Bosnia-Erzegovina, alimentando le tensioni nei Balcani che furono una delle cause principali dello scoppio della Prima guerra mondiale.

L'invasione: la guerra italo-turca
La fragilità dell'Impero ottomano fu uno dei fattori che spinsero l’Italia ad agire. Tuttavia, la spinta finale venne dalla politica aggressiva della Germania. Il kaiser Guglielmo II (1859-1941) era il promotore della Weltpolitik ('politica mondiale'), una politica estera imperialista supportata da un robusto riarmo navale. Nel 1911 la tensione internazionale raggiunse un nuovo picco quando un incrociatore tedesco entrò nel porto marocchino di Agadir, dando vita a una crisi con la Francia per il Marocco. La situazione poteva mettere a repentaglio gli sforzi diplomatici italiani, ma fu anche un'opportunità per l'agognata spedizione in Libia. Giolitti, insieme al ministro degli esteri Antonino di San Giuliano (1852-1914), inviò un ultimatum agli ottomani dichiarandogli guerra il giorno dopo.
La prima fase della guerra in Libia iniziò con il bombardamento delle città costiere di Bengasi e Tripoli, seguito dallo sbarco di truppe italiane il 3 ottobre 1911. Questi attacchi della marina italiana videro l'impiego di aeroplani, per la prima volta utilizzati durante un conflitto. Tuttavia, le operazioni procedevano troppo lentamente per il governo italiano e gli ufficiali ottomani, insieme ai libici, iniziarono a compiere i primi atti di resistenza. Lo scenario era completamente nuovo per le truppe italiane, che non dovevano fronteggiare un esercito regolare bensì una guerriglia organizzata, che era in grado di rispondere efficacemente. Il governo italiano ricevette critiche a livello internazionale: le altre potenze europee temevano che uno scontro prolungato avrebbe potuto avere effetti destabilizzanti al di là della Libia. Il governo italiano dovette fronteggiare anche l'opposizione interna, nonostante il supporto alla guerra dei circoli nazionalisti e di alcuni intellettuali. Il poeta Giovanni Pascoli (1855-1912), per esempio, in un famoso discorso in favore della guerra ("La grande proletaria si è mossa"), collegò l'idea socialista del miglioramento delle condizioni di vita del proletariato italiano con il concetto nazionalista di redenzione dell'orgoglio nazionale. Il partito socialista italiano, anche se era diviso sul tema, si oppose alla conquista di quello che definì uno "scatolone di sabbia" (Salvemini) a causa dei dubbi benefici economici della guerra. Persino Benito Mussolini, in seguito fondatore del fascismo e dittatore dell'Italia, a quel tempo era un fervente antinterventista socialista.
Il governo proseguì con l'annessione formale della Cirenaica e della Tripolitania il 5 novembre, ma la Libia era ben lontana dall'essere realmente sotto il controllo italiano. Dopo questa fase di stallo, le truppe italiane proseguirono verso l'interno. Nonostante avesse conseguito la vittoria in una serie di battaglie, il governo spinse per delle azioni militari contro la Turchia sia sul Mar Rosso che nel Mediterraneo occupando delle piccole isole per mostrare la risolutezza dei piani militari italiani. La fragilità dell'Impero ottomano fu la chiave per i progressi militari in Libia. Gli ottomani dovevano fronteggiare dei tumulti molto più seri nei Balcani e furono costretti a impiegare più truppe in quel settore, nel quale presto sarebbe scoppiata la prima guerra balcanica (1912-1913). Inoltre, l'Italia aveva occupato le isole del Dodecaneso nell'Egeo per mettere ulteriore pressione agli ottomani. Per Costantinopoli era impossibile resistere su entrambi i fronti e, dopo dei colloqui diplomatici con l'Italia iniziati a luglio, il 18 ottobre 1912 venne siglato un trattato di pace a Ouchy.

La politica degli statuti
L'Italia esercitava un controllo effettivo solo sulla costa e lo scoppio della Prima guerra mondiale nel 1914 rese impossibile la capitalizzazione della conquista. La guerra fece anche cadere il governo di Giolitti perché tutti i partiti di opposizione si radicalizzarono verso posizioni anticoloniali. Il trattato di pace non ebbe effetti sulla società libica: ci furono dei proclami in favore della resistenza e il trattato lasciò a Costantinopoli l'autorità di nominare un 'califfo' in Libia, segno che la presenza turca non era ancora stata spazzata via. Nel frattempo, durante il 1913 e il 1914, l'occupazione del Fezzan e della Cirenaica procedeva con difficoltà. La partecipazione italiana alla Prima guerra mondiale a partire dal 1915 indebolì ulteriormente qualsiasi progresso militare e molte località che erano state conquistate vennero riprese dalla resistenza libica, costringendo gli italiani a ripiegare sulle posizioni del 1912 e lasciandogli il controllo della sola area costiera. Per l'opinione pubblica italiana, questa ritirata non fu scioccante come quella della colonizzazione in Eritrea; gli italiani ora erano preoccupati dalle notizie della Grande Guerra. Il governo italiano, così come quello britannico che stava combattendo i Senussi in Egitto, fu dunque costretto a scendere a compromessi in Cirenaica con la confraternita, che godeva ancora di una certa influenza. Con l'accordo di Akrama del 1917, il capo della confraternita Muhammad Idris (1889-1983) mise fine alla rivolta e cessò ogni collaborazione con gli ottomani, ma non ebbe il diritto di mantenere delle truppe armate.
Anche se la situazione in Cirenaica si era stabilizzata, in Tripolitania le ostilità continuavano. Il governo optò per un accordo con l'auto-proclamata repubblica tripolitana che aveva guidato la resistenza fino al 1918. In seguito all'accordo del 1919 con la resistenza di Khallet ez-Zeitun, agli abitanti della Tripolitania fu concesso un patto noto come "statuto libico". I tripolitani non erano più sudditi dell'Italia ma ottennero la 'cittadinanza italiana di Tripolitania', una condizione che, pur essendo differente dalla classica cittadinanza italiana, garantiva il diritto di presentare petizioni al parlamento di Roma e di creare un'assemblea locale che poteva imporre tributi. Lo statuto garantiva inoltre la libertà di stampa e associazione, la promozione della lingua araba e l'abolizione del servizio militare obbligatorio. La 'politica degli statuti', promossa nel dopoguerra dai governi liberali di Vittorio Emanuele Orlando (1860-1952) e Francesco Saverio Nitti (1868-1953), fu estesa anche alla Cirenaica, dove il modus vivendi di Akrama fu sostituito dal patto di ar-Rajma del 1920. Anche gli abitanti della Cirenaica ottennero un parlamento, e i Senussi mantennero sia il controllo militare, grazie al diritto di mantenere truppe attive, che la guida religiosa, sotto l'autorità di Idris che ricevette il titolo di 'emiro della Cirenaica'.
La 'pacificazione' fascista della Libia (1923-1932)
Il sistema degli statuti entrò in crisi quando a Muhammad Idris venne offerto il titolo di 'emiro della Tripolitania'. I capi della resistenza tripolitana non erano soddisfatti dei risultati dell'accordo e decisero di ristabilire la repubblica tripolitana e riprendere le ostilità. Tuttavia, furono presto preda di divisioni interne e così speravano di trovare in Idris un capo che avrebbe potuto guidare la rivolta. Muhammad Idris accettò di fatto il titolo nel novembre del 1922. Questo atto venne visto da Roma come un modo per compattare la resistenza. Il nuovo governo italiano nominò l'intransigente colonialista Giuseppe Girardini (1856-1923) ministro delle colonie e Giuseppe Volpi (1877-1947) governatore della Tripolitania, i quali posero fine alla politica degli statuti. La tregua con i libici non fu riconfermata e nel 1921 ripresero le ostilità. Dopo il primo attacco della resistenza, Volpi lanciò la riconquista di quelle aree delle Tripolitania sotto il controllo italiano prima del 1915.

Nel 1922, con l'avvento del fascismo e la presa del potere a Roma da parte di Mussolini, che iniziò a trasformare l'Italia in una dittatura, si decretò la fine di ogni ulteriore compromesso o patto con i libici. Mussolini incoraggiò le operazioni militari guidate da Volpi che, tra il 1923 e il 1924, inizialmente indebolirono la resistenza. Di fatto, alla fine si venne a creare una nuova e rinvigorita opposizione al comando di Omar al-Mukhtār (1858-1931), un imam che divenne il capo del movimento di resistenza. La situazione sfociò nella seconda guerra italo-senussa o, come venne chiamata dagli italiani, alla 'pacificazione' della Libia. Durante il fascismo, le colonie furono oggetto di una rinnovata attenzione e la Libia non fece eccezione, come dimostrato da una serie di visite di figure di spicco come quella del re Vittorio Emanuele III (1869-1947) in Tripolitania nel 1928 e di Mussolini nel 1926 a Tripoli. Il nuovo tono aggressivo dell'Italia in politica estera richiedeva una reazione più forte in Libia. Il nuovo obiettivo era la conquista del sud della Tripolitania e la riconquista della Cirenaica. Tuttavia, i progressi militari in Tripolitania furono più lenti che in Tripolitania. Mussolini decise, dunque, di impiegare il generale Pietro Badoglio (1871-1956), che intensificò le operazioni militari in Tripolitania con lo scopo di conquistare il Fezzan e iniziare a negoziare in Cirenaica, dove si giunse a una tregua con Omar al-Mukhtār nel 1929.
La tregua non durò a lungo e Mussolini nominò vicegovernatore il generale senza scrupoli Rodolfo Graziani (1882-1955). Graziani, ricordato come il 'macellaio del Fezzan', fu responsabile dell'incremento della violenza che caratterizzò questa seconda fase della guerra. Il generale ordinò l'esproprio delle proprietà dei libici e costrinse le popolazioni che vivevano nell'area di Jebel Akhdar, che avevamo uno stile di vita semi-nomade, a spostarsi verso la costa, dove furono internate in campi di concentramento dopo lunghe marce della morte attraverso il deserto. Il combattimento si intensificò e l'aviazione usò persino il gas mostarda, un'arma chimica proibita formalmente dal 1925. Le genti della Cirenaica furono costrette a adottare un nuovo stile di vita fatto di dure condizioni, con il risultato che la popolazione totale della Cirenaica diminuì di più di un quarto (Mann, 309), contando sia i morti che le persone esiliate o costrette a fuggire. Alla fine, trovatosi isolato, il capo della resistenza Omar al-Mukhtār venne scovato, arrestato e impiccato nel 1931. Con la morte della sua guida, la resistenza collassò e presto l'intera Libia fu 'pacificata'. I campi di concentramento vennero smantellati a partire dal 1932, ma molte persone non furono riportate nei loro luoghi di origine, venendo bensì ricollocate in nuove e insolite località.

Dalla 'diciassettesima regione italiana' all'indipendenza
Quando Italo Balbo (1896-1940) divenne governatore della Libia unificata nel 1934, si aprì una nuova fase. In realtà era stato 'esiliato' da Mussolini, il quale temeva che la popolarità di Balbo potesse intaccare il suo potere. Balbo spinse per integrare Tripolitania e Cirenaica come parte dell'Italia nel 1939, in qualità di diciassettesima regione italiana. Provò anche a integrare i libici mediante la costruzione di nuovi villaggi dotati di moschee e la costruzione di imponenti infrastrutture, come la 'Via Balbia', una strada statale che corre lungo la costa libica. Il governatore tentò di dare la piena cittadinanza italiana ai libici, che lui considerava 'italiani musulmani della quarta sponda d'Italia', ma Mussolini rifiutò. Balbo si impegnò anche per la 'colonizzazione dei ventimila', un trasferimento di massa di contadini italiani in Libia nel 1938. Tuttavia, i progetti del governatore della Libia ebbero una fine inaspettata quando l'aeroplano che stava pilotando fu abbattuto da fuoco amico italiano il 28 giugno del 1940.
La Seconda guerra mondiale (1939-1945) arrivò in Libia durante un periodo di grande colonizzazione demografica. Mentre l'Africa Orientale Italiana collassò nel 1941, la Libia fu il teatro della campagna del Nordafrica (1940-1943), nella quale le truppe italiane e tedesche combatterono per il controllo di Libia ed Egitto. Dopo la vittoria degli Alleati, la Libia cadde prima sotto il controllo militare di Gran Bretagna e Francia, ottenendo poi l'indipendenza nel 1951 in qualità di regno sotto il controllo di Idris, il capo dei Senussi. Le relazioni tra Italia e Libia, specialmente dopo la rivoluzione di Muammar Gheddafi (1942-2011) nel 1969, sono state caratterizzate da discussioni sulla compensazione dei danni sofferti durante il periodo del colonialismo italiano. Nel 1970, Gheddafi confiscò tutte le proprietà degli italiani che erano rimasti in Libia dopo la guerra, costringendoli a lasciare il paese. Solo nel 2008 Italia e Libia hanno raggiunto un accordo sulle compensazioni.