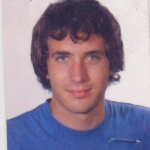La battaglia di Stalingrado, attuale Volgograd, durò dal luglio del 1942 al febbraio del 1943 e fu il tentativo con cui Adolf Hitler (1889-1945) cercò di ottenere l'accesso ai giacimenti petroliferi del Caucaso. L'Armata Rossa sostenne dei feroci combattimenti urbani con cui la città resistette all'attacco fino a quando non fu lanciata una massiccia controffensiva che intrappolò la 6ª Armata tedesca.
La battaglia, considerata un punto di svolta della guerra tedesco-sovietica, terminò con la distruzione di un'intera armata e la resa di 91.000 soldati, compreso il feldmaresciallo Friedrich Paulus (1890-1957). Fu una delle più grandi vittorie sovietiche nel corso della Seconda guerra mondiale (1939-45): gli eserciti di Hitler non si ripresero più e da quel momento in poi combatterono una guerra difensiva in ritirata.

La campagna fino a quel momento
Adolf Hitler, capo della Germania nazista, aveva attaccato l'Unione Sovietica nel giugno del 1941 con l'operazione Barbarossa. I tedeschi ottennero presto delle vittorie imponenti grazie alle tattiche della Blitzkrieg ("guerra lampo"), che combinavano il supporto aereo con le divisioni corazzate e di fanteria in rapido movimento che avanzavano su fronti stretti. Quando però si trattò di prendere delle grandi città, gli invasori ebbero meno successo. La battaglia di Mosca, svoltasi dall'ottobre del 1941 al gennaio del 1942, vide la vittoria dell'Armata Rossa. Anche l'assedio di Leningrado si protrasse per anni, e la città riuscì a resistere. Stalingrado, situata nel sud dell'URSS, si sarebbe rivelata un obiettivo altrettanto duro per le forze dell'Asse.
La città di Stalin
Stalingrado (letteralmente "città di Stalin") era la vecchia Zaritsyn, rinominata nel 1925 in onore del capo dell'URSS Iosif Stalin e che dal 1967 in poi si sarebbe chiamata Volgograd. Stalingrado aveva posseduto a lungo una fortezza, che era la ragione stessa dell'esistenza della città, che proteggeva il collegamento tra i fiumi Volga e Zaritsa e l'accesso ai confini meridionali della Russia. Si trattava di un centro industriale di grande importanza attraverso il quale passavano rifornimenti vitali per lo sforzo bellico sovietico, compreso il petrolio del Caucaso. Se Hitler avesse preso la città, "i sovietici avrebbero ricevuto un colpo economico devastante" (Rees, 142).
Gli eserciti contrapposti
L'obiettivo di prendere Stalingrado tramite l'operazione Airone fu assegnato al generale Paulus, comandante della 6ª Armata, la più grande dell'esercito tedesco. Paulus aveva poca esperienza sul campo di battaglia perché fino a quel momento aveva servito come ufficiale di stato maggiore. Aveva fornito assistenza nella pianificazione dell'operazione Barbarossa e, nel maggio del 1942, aveva contribuito alla vittoria nella seconda battaglia di Kharkov. In totale, le forze dell'Asse che si scagliarono contro Stalingrado ammontavano a poco meno di 300.000 uomini (Antill, 54).

A Stalingrado erano presenti anche la 4ª Armata corazzata del generale Hermann Hoth (1885-1971) e il gruppo d'armate B del generale Maximilian von Weichs (1881-1954). Inoltre, c'erano anche diversi eserciti alleati della Germania, posizionati ai fianchi del fronte di Stalingrado, tra cui romeni, ungheresi e italiani; costoro non avevano l'esperienza né erano addestrati ed equipaggiati come la loro controparte tedesca.
Il difficile problema della difesa di Stalingrado, che si estendeva per circa 40 chilometri sulla riva occidentale del Volga, era stato affidato alla 62ª Armata del general maggiore Vasilij Čujkov (1900-1982). Conosciuto dai suoi uomini con il soprannome di "general caparbietà" e famoso per il suo scintillante sorriso dovuti ai denti d'oro, Čujkov promise a Stalin che "terremo la città o moriremo lì" (Dear, 183). A Stalingrado, l'Armata Rossa contava 54.000 soldati (Antill, 54); Čujkov però ricevette continui rinforzi e materiali dalla riva orientale del Volga.
Dopo la vittoria nella battaglia a est di Kalach e la cattura di 50.000 prigionieri sovietici, il 7 agosto Paulus si spinse verso Stalingrado. A causa della facilità dell'avanzata, Hitler tolse alla 6ª Armata alcune delle sue divisioni corazzate per spostarle negli scontri in corso nel Caucaso. Verso la fine di agosto, Paulus iniziò a radunare le sue truppe per un attacco frontale sulla città, ora distante solo 15 chilometri. Il 29 agosto, il generale Georgij Žukov (1896-1974) prese il comando generale dell'ampio fronte di Stalingrado e pianificò una controffensiva, l'operazione Urano, che sarebbe iniziata a novembre. Žukov fu poi spostato altrove, e l'esecuzione dell'operazione Urano fu lasciata nelle mani del generale Aleksandr Vasilevskij (1895-1977).

I combattimenti urbani a Stalingrado
Il 19 luglio, Stalingrado era pronta a combattere. Stalin aveva deciso che, per il morale dell'intero paese, la città che portava il suo nome avrebbe dovuto resistere a qualsiasi costo. Venne creata una milizia locale che comprendeva anche donne, che entrarono a far parte anche delle molte unità contraeree cittadine. Ogni isolato, strada e edificio doveva essere tenuto il più a lungo possibile.
Il 4 agosto l'esercito dell'Asse attraversò il fiume Aksaj e si diresse verso la città. Il 19 agosto, Paulus ordinò alla 6ª Armata di attaccare Stalingrado. I confini esterni del centro abitato furono raggiunti il 3 settembre. Dal 23 al 26 agosto, in preparazione del primo assalto terrestre, Stalingrado fu bombardata ripetutamente e indiscriminatamente da 600 velivoli dell'Asse. Gli invasori misero piede nel vero e proprio centro urbano il 12 settembre 1942. Paulus avrebbe ordinato altri due assalti, il 27 settembre e il 14 ottobre. Per minimizzare le perdite causate dai bombardamenti e dal fuoco dell'artiglieria, ai soldati sovietici venne ordinato di stare quanto più vicini possibile alle posizioni dell'Asse.
I combattimenti furono spesso brutali perché le macerie, le trincee, le fogne e i passaggi sotterranei dovevano essere sgombrati metro per metro. I cecchini di entrambe le parti rendevano fatale qualsiasi movimento avventato. I carri armati sovietici furono deliberatamente nascosti tra le macerie e sparavano sul nemico in totale sorpresa. I soldati tedeschi chiamarono questo insolito stile di combattimento Rattenkrieg, ossia "guerra dei topi". Mentre i comandanti dell'Asse avevano difficoltà nel gestire i loro uomini in queste condizioni, Čujkov impiegò in maniera innovativa dei gruppi d'assalto di 50-100 soldati a cui diede assoluta autonomia nei combattimenti con i nemici in cui si imbattevano.

Il soldato Wilhelm Hoffman della 6ª Armata riporta nel suo diario la ferocia dei combattimenti:
11 settembre: il nostro battaglione combatte nei sobborghi di Stalingrado. Si spara continuamente. Le fiamme e il fuoco sono dovunque. Le mitragliatrici e i cannoni russi sparano fuori dalla città in fiamme - fanatici!
16 settembre: il nostro battaglione insieme ai carri armati attacca il silos del grano. Il battaglione sta avendo perdite pesanti. Il silos non è occupato da uomini, ma da diavoli che né i proiettili né le fiamme riescono a distruggere.
18 settembre: si combatte dentro il silos. Se tutti gli edifici di Stalingrado sono difesi come questo, nessuno dei nostri soldati farà ritorno in Germania.
(Holmes, 285)
Anton Bosnik, un soldato sovietico, spiega perché era così difficile sgombrare gli edifici dai propri difensori:
Tornammo indietro occupando un edificio dopo l'altro, trasformandoli in fortezze. Un soldato strisciava fuori da una posizione occupata solo quando il terreno era in fiamme sotto di lui e i suoi vestiti bruciavano.
(ibid)

Il 26 ottobre, Hoffman stava ancora combattendo ma sul suo diario annota: "i soldati definiscono Stalingrado la fossa comune della Wehrmacht" (ibid). Un altro soldato, il tenente Reiner delle 4ª Armata corazzata, scrive in una lettera a casa:
Stalingrado non è più una città. Di giorno è un'enorme e accecante nuvola di fumo che brucia, una vasta fornace illuminata dal riflesso delle fiamme. Quando arriva la notte, una di quelle notti molto calde, rumorose e sanguinose, i cani si tuffano nel Volga e nuotano disperatamente per raggiungere l'altra riva. Le notti di Stalingrado li terrorizzano. Gli animali fuggono da questo inferno. La pietra più dura non può sopportarlo a lungo. Solo gli uomini resistono.
(Holmes, 286)
Quando le forze dell'Asse controllavano ormai i nove decimi della città, l'8 novembre Hitler fece un avventato discorso in cui dichiarò che Stalingrado era praticamente caduta. L'Armata Rossa però aveva altre idee e lanciò un'enorme controffensiva. Ai gruppi d'armate a nord e a sud della città fu ordinato di attaccare sull'intero fronte, compiendo due manovre a tenaglia per effettuare l'audace accerchiamento della 6ª Armata. Per settimane, l'Armata Rossa aveva accumulato le sue forze, muovendosi solo di notte, mantenendo il silenzio radio e mimetizzando le masse di carri armati e fanteria: pur non ottenendo una sorpresa totale, le dimensioni dell'operazione sconvolsero il nemico.

La sacca della 6ª Armata
I punti deboli dello schieramento dell'Asse sul fronte di Stalingrado erano la 3ª e 4ª Armata rumena, l'8ª Armata italiana e la 2ª Armata ungherese. Il 19 novembre, il tenente generale Nikolaj Fëdorovič Vatutin (1901-1944) si diresse con tre armate di cui una corazzata contro la 3ª Armata rumena, dando inizio all'operazione Urano. Prima che l'Armata Rossa si muovesse nella tempesta di neve, le linee nemiche furono colpite da un massiccio bombardamento d'artiglieria. Il 20 novembre, la 4ª Armata rumena fu attaccata dalla 52ª Armata sovietica del tenente generale Andrej Erëmenko (1892-1970). Le ali dello schieramento dell'Asse cedettero completamente e, il 23 novembre, con la chiusura della tenaglia vicino Kalach, la 6ª Armata era circondata.
Paulus chiese a Hitler il permesso di ritirarsi con i suoi 250.000 uomini dalla sacca di Stalingrado, che misurava circa 60 chilometri da est a ovest e 45 chilometri da nord a sud. Hitler si rifiutò di permettere la ritirata, come aveva fatto molte volte nel corso della campagna, ma promise di rifornire Paulus con un ponte aereo. Hermann Göring (1893-1946), che era a capo della Luftwaffe, ossia la forza aerea tedesca, aveva promesso a Hitler di riuscire a consegnare 300 tonnellate di rifornimenti vitali ogni 24 ore. Gli studi avevano già rivelato che era impossibile rifornire la 6ª Armata di quanto aveva bisogno per la mancanza di aeromobili da trasporto adatti, copertura dei caccia, e le cattive condizioni metereologiche. Ciononostante, Hitler si aggrappò alle promesse di Göring come a una disperata ancora di salvezza e, per solidarietà con le privazioni dei soldati a Stalingrado, proibì il consumo di champagne e cognac nel suo quartier generale, almeno per alcune settimane.
Uno dei più grandi risolutori di problemi militari di Hitler, il feldmaresciallo Erich von Manstein (1887-1973), organizzò una grande forza di soccorso. Questa forza, comandata sul campo dal generale Hermann Hoth (1885-1971), era composta da tre divisioni corazzate e da due di fanteria. Il piano, chiamato operazione Tempesta Invernale, prevedeva di aprire un corridoio nell'anello nemico intorno alla 6ª Armata, che avrebbe permesso a Paulus di ritirarsi. Von Manstein insisteva sul fatto che questa manovra di soccorso, per essere efficace, doveva prevedere la collaborazione di Paulus, il quale si sarebbe dovuto congiungere con l'avanzante Hoth, ma Hitler ordinò alla 6ª Armata di non muoversi da Stalingrado. La forza di soccorso di Hoth iniziò l'attacco il 12 dicembre.

I sovietici risposero alla forza di soccorso che si avvicinava da sud attaccando l'8ª Armata italiana il 16 dicembre. I sovietici ora spingevano su Stalingrado sia da ovest che da sud. Il 19 dicembre, Hoth riuscì ad addentrarsi nella sacca per 48 chilometri, ma non riuscì ad andare oltre. Se la 6ª Armata si fosse mossa, probabilmente si sarebbe potuta riunire con successo con l'armata di Hoth, ma Hitler continuava a respingere questa opzione.
Nel frattempo, i soldati di Paulus ricevevano solo 90 tonnellate di rifornimenti al giorno, che erano totalmente inadeguati per i loro bisogni, dato che Paulus aveva stimato un minimo di 750-800 tonnellate al giorno. Quel che è peggio, il 28 dicembre, von Manstein fu obbligato a ritirare le truppe di Hoth dalla battaglia perché correvano il rischio di essere accerchiate a loro volta. La 6ª Armata era isolata.
Nel gennaio del 1943, la sacca di Stalingrado riceveva una media di 120 tonnellate di rifornimenti al giorno, che però non erano sufficienti e i soldati erano a resistere con razioni di cibo misere. Le condizioni sotto le forti nevicate sono qui descritte da Bernhard Bechler:
Quando mi sdraiavo e mettevo la mano sotto il colletto, la mia mano si riempiva di pidocchi. E i pidocchi portavano il tifo... Non avevamo niente da mangiare. C'erano alcuni cavalli congelati e prendemmo un'ascia per tagliare della carne e riscaldarla in una pentola solo per avere qualcosa da mangiare. Eravamo lì sdraiati, senza cibo, quasi congelati a morte, era terribile.
(Rees, 182)

L'8 gennaio, una delegazione dell'Armata Rossa invitò Paulus ad arrendersi. Paulus chiese a Hitler libertà di azione per ottemperare alla richiesta, ma la possibilità di arrendersi gli fu negata ancora una volta. Hitler credeva che ogni giorno di resistenza in più della 6ª Armata avrebbe aiutato le forze dell'Asse a sud a evitare di essere tagliate fuori dall'avanzata sovietica.
Vennero evacuati dalla sacca appena 30.000 feriti, portati via su aerei da trasporto vuoti. Per quelli che restarono, continuare a combattere era diventato impossibile, come descritto da Bechler:
Un giorno tre soldati dell'Armata Rossa si avvicinarono alla nostra trincea. Vivevamo lì, il mio aiutante - un giovane tenente - e io...Improvvisamente questi soldati sovietici vennero verso di noi. In un istante, pensammo entrambi "non abbiamo munizioni, questa è era la fine. Ci spareranno o ci faranno prigionieri. Cosa facciamo?" A quel punto, vidi il mio aiutante tirare fuori una foto dalla tasca della giacca della sua uniforme. La guardai, ed era una foto di sua moglie con due bambini molto piccoli. Lui diede un'occhiata alla foto, la strappò, prese la pistola, si sparò in testa ed era morto... Un momento dopo il soldato dell'Armata Rossa era su di me. Mi puntò la pistola al petto, ma non premette il grilletto, e a quel punto, quando capii che non mi avrebbe sparato, iniziò la mia seconda vita.
(Rees, 184)
Il 10 gennaio, dopo un enorme bombardamento, un'armata sovietica al comando del tenente generale Konstantin Rokossovskij (1896-1968) penetrò nella sacca, arrivando circa a metà strada nel giro di una settimana. Paulus adesso aveva solo una base aerea operativa, e si stava rifugiando in un seminterrato di un centro commerciale bombardato. Il 24 gennaio, un'altra delegazione sovietica offrì nuovamente a Paulus la possibilità di arrendersi. Ancora una volta, il generale sotto assedio chiese il permesso a Hitler. Il Führer rispose con il seguente messaggio:
Arrendersi è proibito. La 6ª Armata terrà le sue posizioni fino all'ultimo uomo e all'ultimo proiettile; la sua eroica resistenza darà un contributo indimenticabile alla creazione di un fronte difensivo e alla salvezza del mondo occidentale.
(Shirer, 930)

Ormai erano rimaste solo due piccole sacche a offrire una resistenza efficace. Il 30 gennaio, Hitler decise di promuovere Paulus al grado di feldmaresciallo; molti storici ritengono che sia stata una mossa per indurre Paulus al suicidio. Il suo credo gli impediva di compiere un tale gesto, come disse al comandante di battaglione Gerhard Hindenlang il 30 gennaio:"Hindenlang, io sono cristiano. Mi rifiuto di suicidarmi." (Rees, 185). Il 31 gennaio, Paulus ordinò la resa della sacca in cui si trovava lui, ma non fece altrettanto per l'altra. Hitler ordinò di combattere fino alla morte. Il 2 febbraio, anche l'ultima resistenza tedesca fu sopraffatta dall'Armata Rossa.
Per la prima volta nella storia dell'esercito tedesco, un feldmaresciallo si era arreso. A Stalingrado, la 6ª Armata aveva perso circa 275.000 uomini. I morti furono 150.000 e i sovietici fecero 91.000 prigionieri (di questi, 20.000 erano feriti), tra cui 24 generali. Paulus era stato criticato per non aver disobbedito agli ordini di Hitler, dato che molti altri comandanti in situazioni simili lo avevano fatto. Questo fattore ci viene fatto notare dallo storico M. M. Boatner: "un generale più duro, deciso ed esperto avrebbe potuto salvare qualcosa dalla campagna" (417). Anche gli alleati dei tedeschi subirono perdite pesanti. Tra morti e feriti, l'Italia perse 110.000 uomini, l'Ungheria 143.000 e la Romania 160.000. Questi paesi non riuscirono a rimpiazzare perdite così grandi. Dall'altra parte, la vittoria sovietica arrivò a un prezzo molto alto. A Stalingrado, per fame o per il fuoco nemico, morirono due milioni di civili (Rees, 177).
Conseguenze
Hitler annunciò la sconfitta al popolo tedesco via radio il 3 febbraio, terminando la comunicazione con il secondo movimento della Sinfonia n. 5 di Ludwig van Beethoven (1770-1827). In segno di rispetto per i caduti, il Führer dichiarò quattro giorni di lutto nazionale, durante i quali vennero chiusi tutti i teatri e i cinema.

Le lunghe operazioni a Stalingrado permisero alle truppe dell'Asse del gruppo d'armate A di ritirarsi da sud ed evitare un destino simile a quello della 6ª Armata. I tedeschi erano certamente in grado di continuare a combattere, ma la sconfitta di Stalingrado mostrò anche che non avrebbero mai potuto vincere una guerra d'attrito contro l'URSS, che aveva una produzione industriale e una capacità di rimpiazzare le perdite molto maggiori. La sconfitta ebbe un forte impatto psicologico, come notato dallo storico J. Dimbley:"fu una catastrofe per il Terzo Reich, un colpo devastante al suo morale già scosso" (498). Per l'Unione Sovietica, il successo nella difesa di Stalingrado fu un punto di svolta della guerra. La città era stata distrutta dalla battaglia, ma fu ricostruita e ottenne il titolo di "città eroica".
La Seconda guerra mondiale in Europa terminò con la presa di Berlino nel maggio del 1945. Dopo la guerra, il feldmaresciallo Paulus testimoniò al processo di Norimberga e fu rilasciato dalla prigionia sovietica nel 1953. Paulus ebbe una sorte migliore di molti dei suoi compatrioti: dei 91.000 uomini finiti nei campi di prigionia sovietici dopo la resa di Stalingrado, solo circa 5.000 tornarono a casa.